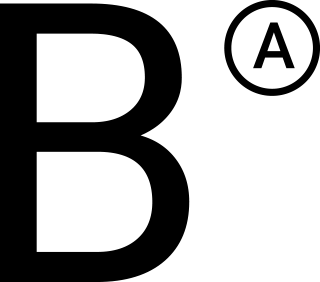Viviamo in un territorio ad alta densità abitativa, in un Veneto che non sembra più palesare una forte cesura tra aree urbane ed aree agricole, tra città e campagna. La nostra regione appare piuttosto come un’enorme distesa, che si svolge senza soluzione di continuità dalla fascia pedemontana al mare Adriatico, fatta di una miriade di case, di giardini, di campi coltivati, di capannoni, di palazzine, di edifici rurali, di ville palladiane, di villette unifamiliari, di case a schiera e quant’altro, gli uni quasi giustapposti agli altri senza un particolare criterio.
Esiste poi una quantità smisurata di leggi, regolamenti e vincoli che nel corso degli anni hanno tentato di governare o dominare questo fenomeno di urbanizzazione diffusa. Tuttavia i risultati di cinquant’anni di pianificazione rimangono modesti e sotto gli occhi di tutti. Lo zooning ha mostrato gravi insufficienze nel governare la produzione edilizia durante lo sviluppo urbano ed i regolamenti delle amministrazioni locali, uniti ad una burocrazia oramai esasperata ed esasperante, non hanno prodotto e continuano a non produrre alcun miglioramento della qualità costruttiva locale. Al contrario, nella stragrande maggioranza dei casi la maggior parte di queste norme ingabbiano idee all’interno di schemi stanchi e superati, che mortificano al contempo il concetto architettonico originario, il progetto e il progettista stesso.
È dato pensare che l’immagine di un territorio frammentario e sregolato induca gli organi di governo e di controllo a supporre che solo una maggiore regolamentazione, unita ad un controllo più puntuale, possa contrastare un ulteriore sviluppo di questo territorio informe e disorganizzato. Salvo poi ammettere, o sarebbe meglio dire concedere, una quantità altrettanto infinita di eccezioni che possono derogare dalla regola ferrea, eccezioni di cui beneficiano (solo) coloro che hanno le potenzialità economiche o le giuste conoscenze, queste ultime raramente di carattere scientifico, che vengono fatte valere a tutti i livelli, sia che riguardino grandi interventi a valenza territoriale, sia che riguardino piccoli interventi privati nella frazione più sperduta.
Affermazioni quali Chi è che ha autorizzato quell’obbrobrio? Sarebbe da licenziare su due piedi! o Quell’ecomostro grida vendetta! Ma chi glielo ha permesso? divengono litanie popolari ripetute ad ogni piè sospinto, con l’intento di sortire chissà quale affetto taumaturgico sul realizzato. Ma approfondendo il giudizio, si viene spesso a scoprire che la maggior parte di quegli stessi interventi non sono abusi edilizi ma risultano perfettamente in regola con tutte le norme locali e con i vincoli storici e ambientali.
Viene dunque da chiedersi quale sia allora il senso di uno sterminato elenco di prescrizioni quando alla fine solo gli interventi comuni, quelli più insignificanti, siano costretti a rispettarlo. Forse, provocatoriamente, sarebbe meglio ritornare ad una edilizia libera generalizzata, che nel suo spirito libertario quantomeno sia uguale per tutti.
Anche nei casi in cui circostanze favorevoli e una forte volontà politica hanno consentito di realizzare uno sviluppo urbano fedele alle prescrizioni del P.R.G., è emerso che l’azzonamento non riesce a cogliere le esigenze di qualità contemporanee, che si esprimono nell’integrazione piuttosto che nella distinzione funzionale, dimostrandosi così incapace di incentivare interventi di riqualificazione tesi a ricercare una nuova e più complessa qualità delle città1.
Infatti la qualità costruttiva di un territorio, storicamente, non è mai stata imposta con editti ma era il frutto dello spirito di un luogo, delle risorse locali e delle abilità dei propri abitanti. L’uniformità che riscontriamo nei centri storici delle nostre splendide città, un’uniformità che tanto apprezziamo, è il risultato della stratificazione, dello sviluppo e del perfezionamento della stessa tecnica costruttiva per la quale i muri erano in mattoni pieni, i solai in legno ed i tetti con manto in coppi a due falde o a padiglione. Le forme erano necessariamente semplici e, ad eccezione degli edifici extra-ordinari come le chiese, le sedi di potere o i palazzi signorili, non si riesce a colpo d’occhio a distinguere un edificio dall’altro. Anche quando si trattava di modificare un edificio, l’omogeneità dei materiali impiegati ed il persistere delle medesime tecniche costruttive garantivano una sorta di integrazione e di continuità del nuovo intervento con l’edificio originario.
In epoca moderna, soprattutto grazie all’impiego del calcestruzzo armato, si è verificata invece una esplosione di forme: risulta oggi possibile realizzare qualsiasi forma ideata dall’ingegno del progettista e, a torto o a ragione, ogni forma è stata realizzata. Vi è da dire però che questo moderno paradigma costruttivo, che amplia il ventaglio di possibilità e diversifica all’inverosimile i vari edifici realizzati, vale tanto per le menti illuminate di brillanti innovatori quanto per gli epigoni di infima serie, e le leggi democratiche non fanno (e non lo devono fare!) distinzione tra i primi ed i secondi, finendo però per dar spazio alla costruzione di quella massa informe che è il nostro territorio.
Personalmente non ritengo che si riesca ad uscire da questa situazione meramente per via normativa, seguendo la semplicistica istanza del si faccia una legge per evitare questo o quell’altro. Al contrario è mia profonda convinzione che soltanto una cultura architettonica diffusa tra la popolazione e la cittadinanza renda consapevoli dello spirito di un territorio e al contempo metta nella condizione di prendere atto che non ha importanza il singolo intervento edilizio, ma la città nel suo insieme.
Purtroppo mancano soluzioni spicce o preconfezionate: se queste vi fossero questo scritto non avrebbe ragione di esistere e forse, in tempi di forte coscienza ecologica, alcuni detrattori potrebbero affermare che si tratti dell’ennesimo spreco di carta e inchiostro. Tuttavia è mia opinione che sarebbero sufficienti poche regole ma molto chiare ed inderogabili per governare un territorio. Questa può sembrare una visione semplicistica della realtà, ciononostante esistono interventi che rappresentano il principio minimalistico di un’onesta semplificazione: il piano di Monte Carasso elaborato da Luigi Snozzi può essere sicuramente un esempio a cui guardare2. Interessanti sono anche le esperienze di pianificazione fatte in paesi come l’Olanda, la Danimarca o la Germania, paesi nei quali si cerca di sviluppare le aree urbane non per via esclusivamente normativa, ma coinvolgendo organicamente tutti gli attori del territorio. In casi come questi si è operato attraverso progetti sostanzialmente delimitati, morfologicamente identificabili, funzionalmente e figurativamente connessi al proprio intorno, in grado di stimolare e controllare ulteriori sviluppi dei processi di riedificazione, riqualificazione e riuso di estese aree urbane.
Alla base di tutto vi dev’essere comunque una idea di città, una visione concreta che incida sulla realtà del territorio: alcuni modelli condivisi da seguire e da declinare nei singoli interventi. Ed è in virtù di tale idea che è possibile affermare che senza la condivisione di alcuni principi fondamentali di riferimento, quali l’omogeneità, la semplicità, la durata e la disponibilità alla trasformazione, nessun nuovo apparato normativo ritenuto assolutamente necessario riuscirà a plasmare un contesto ordinato, «un impianto di fondazione, che potrà diventare traccia archeologica destinata a durare nel tempo, e base per organizzazioni diverse degli spazi e delle funzioni, come è avvenuto per secoli nelle città antiche»3.
Note:
1 Cfr. B. Secchi, La periferia, in Casabella 583, ottobre 1991, pp. 20-22. Per un approfondimento del tema si veda anche Brescia: il nuovo piano regolatore, a cura di B. Secchi, Grafo, Brescia 1998
2 Cfr. P. Disch, Luigi Snozzi. L’opera completa, ADV Publishing House, Lugano 2005, pp. 154-165
3 M. Carmassi, Idee di Città, Libria, Melfi 2011, p. 19